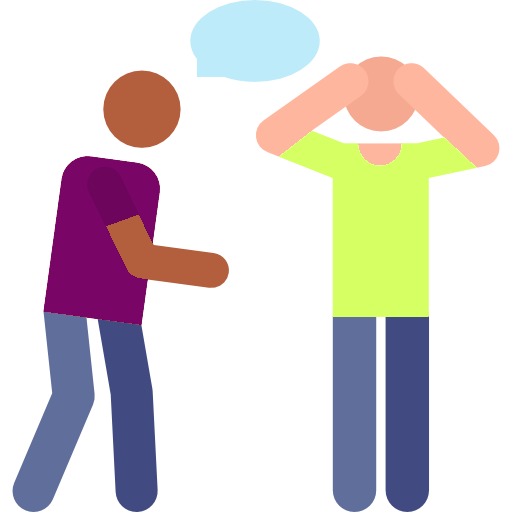
Guida ai giochi psicologici: perché non sia sempre la stessa storia
Hai mai avuto la sensazione di essere finita in una discussione che sembrava razionale ma che alla fine ti ha lasciata svuotata, confusa o arrabbiata? Magari con un collega che ti chiede un consiglio, poi trova mille motivi per cui non può seguirlo, ma continua a chiederti soluzioni? O con un capo che ti fa sentire sempre inadeguata, nonostante i tuoi risultati siano ottimi?
I giochi psicologici sono proprio così: scambi che sembrano delle normali conversazioni, ma nascondono dinamiche ripetitive, prevedibili e alla fine frustranti per tutti i partecipanti.
Eric Berne, il padre dell’Analisi Transazionale, ha iniziato a studiare questi pattern negli anni ’60 e li ha definiti “giochi” perché come i giochi sono ripetitivi, hanno delle regole e alla fine c’è qualcuno che vince, solo che non sono divertenti. Sono trappole relazionali in cui cadiamo (quasi) inconsapevolmente cercando di soddisfare bisogni profondi, ma che ci allontanano dal farlo.
Nei contesti professionali riconoscere questi pattern può fare la differenza tra sentirsi costantemente sotto pressione e stare nelle relazioni con maggiore consapevolezza e serenità.
Perché è importante parlarne oggi
In un mondo professionale in continuo cambiamento, con comunicazioni sempre più veloci e relazioni spesso mediate da schermi, le dinamiche relazionali diventano ancora più complesse. I giochi psicologici non sono solo una “stranezza” delle persone difficili: sono risposte automatiche a bisogni interni non esplicitati, spesso agite in buona fede.
Capita a tutte e tutti di finire in questi copioni: aiutare anche quando non serve, evitare un confronto diretto, cedere per “non fare storie”, cercare approvazione mascherando un malessere. Non è debolezza: è un tentativo (non sempre efficace) di stare a galla.
Imparare a riconoscere quando stiamo partecipando a un gioco psicologico non è solo una competenza relazionale: è un atto di autocura che ci permette di investire le nostre energie in modo più consapevole e sostenibile.
L’angolo della teoria – Analisi Transazionale in pillole
Raccolgo qui tutti i concetti teorici di cui ho parlato in questa guida, in modo che tu possa avere un punto di riferimento se ne hai bisogno.
Stati dell’Io
Secondo l’Analisi Transazionale (AT), comunichiamo attraverso tre “stati” interiori:
Genitore
Raccoglie regole, valori, giudizi interiorizzati dalle figure significative della nostra vita. Può essere quello che ci ricorda quali sono le regole (Genitore Normativo, positivo o negativo), oppure protettivo e premuroso (Genitore Affettivo, positivo o negativo). Esiste anche il Genitore Culturale, che raccoglie tutto quello che abbiamo interiorizzato dalla nostra cultura di riferimento.
Adulto (integrato)
È la parte centrata nel presente, capace di analizzare i dati, valutare le alternative e prendere decisioni consapevoli. Integra gli insegnamenti Genitoriali e le reazioni Bambine in modo che rispondano coerentemente agli stimoli della realtà del presente.
Bambino
Rappresenta il mondo emotivo e l’esperienza vissuta. Può essere Libero (spontaneo, creativo), Adattato (compiacente o sottomesso) o Ribelle (oppositivo, provocatorio).
Nei giochi psicologici, spesso ciò che diciamo e ciò che comunichiamo davvero provengono da Stati dell’Io diversi (la comunicazione verbale proviene dall’Adulto, il tono di voce e il resto della comunicazione non verbale dal Genitore o dal Bambino). Questo crea ambiguità, malintesi e reazioni sproporzionate.
Il triangolo drammatico
Stephen Karpman, allievo di Berne, ha descritto una dinamica ricorrente nei giochi relazionali: tre ruoli che si alternano, generando tensione e frustrazione.
Il gioco funziona perché questi ruoli si scambiano continuamente: chi inizia da Salvatore può diventare Vittima, chi appare come Vittima può trasformarsi in Persecutore. Riconoscere questa danza è fondamentale per interromperla.
Il contratto
In AT, un contratto è un accordo chiaro su cosa si vuole ottenere e come si intende farlo. Nei rapporti professionali, dichiarare ruoli, responsabilità e aspettative riduce lo spazio per ambiguità e giochi relazionali.
Un contratto può essere anche implicito, ma quando è esplicito e condiviso diventa una vera risorsa.
Le carezze
Con questo termine si indicano tutti i riconoscimenti che ci scambiamo: parole, gesti, sguardi, attenzioni. Le carezze possono essere positive o negative, condizionate (“Se fai bene ti apprezzo”) o incondizionate (“Mi piace lavorare con te, punto”).
Quando le carezze positive mancano, spesso giochiamo per ottenerle in modo disfunzionale. Anche la critica può diventare una carezza, se è l’unico modo che conosciamo per sentirci viste.
Il guadagno psicologico
Ogni gioco ha un “premio” nascosto: anche se ci lascia frustrate o stanche, ci conferma qualcosa che già pensiamo di noi, degli altri o del mondo. È proprio questo guadagno implicito che rende difficile uscire dal gioco: ci racconta una storia conosciuta, anche se ci fa male.
Cosa sono i giochi psicologici
Un gioco psicologico, nel linguaggio dell’Analisi Transazionale, è una serie di transazioni complementari apparentemente logiche ma con una motivazione nascosta (diventano quindi transazioni ulteriori), che si conclude con uno stato emotivo confuso e spiacevole per tutti i partecipanti.
Hanno alcune caratteristiche specifiche:
Le caratteristiche di un gioco
Un esempio per iniziare a capire
Immagina questa situazione:
Collega: “Sono disperata, ho questo progetto impossibile e non so come fare” (Stato dell’Io: Bambino Adattato)
Tu: “Posso aiutarti, che cosa non ti è chiaro?” (Stato dell’Io: Genitore Affettivo)
Collega: “Sì, ma il cliente è impossibile” / “Ho già provato, non funziona” / “È troppo complicato” (Bambino Ribelle)
Tu (dopo un po’): “Ma allora che cosa vuoi che faccia?” (Genitore Critico)
Collega: “Niente, tanto nessuno mi capisce!” (Bambino Adattato)
Ti suona familiare? Questo è un esempio del gioco “Perché non… si ma“, dove chi chiede aiuto in realtà non cerca una soluzione, ma la conferma che la situazione è impossibile e che è vittima delle circostanze.
Il triangolo drammatico: la mappa dei giochi
Stephen Karpman (allievo di Berne) ha creato uno strumento prezioso per capire meglio i giochi psicologici: il triangolo drammatico. È una mappa che ci aiuta a vedere i ruoli che assumiamo nei giochi e come questi ruoli si alternano.
I tre ruoli del triangolo
Persecutore
Critica, accusa, sminuisce. Opera dal Genitore Critico: “È colpa tua“, “Non vali niente“, “Sei sempre la solita“.
Salvatore
Interviene per “aiutare” senza che gli sia stato chiesto. Opera dal Genitore Affettivo ma con un sottotesto di superiorità: “Lascia fare a me“, “Senza di me non ce la fai“.
Vittima
Si presenta come impotente, subisce passivamente. Opera dal Bambino Adattato: “Non posso farci niente“, “Capitano tutte a me“, “Non sono capace“.
La danza dei ruoli
Nel triangolo drammatico i ruoli si scambiano continuamente. Chi inizia come Vittima può diventare Persecutore, il Salvatore può ritrovarsi Vittima, e così via. È questa danza che mantiene vivo il gioco.
Nell’esempio che abbiamo visto prima:
- La collega inizia come Vittima
- Tu diventi Salvatore
- Lei si trasforma in Persecutore (rifiutando tutti i tuoi suggerimenti)
- Tu diventi Vittima (frustrata e svalutata) o Persecutore (impaziente e critica)
Bias di genere nel triangolo
Nei contesti lavorativi, spesso chi è socializzata come donna viene spinta verso il ruolo di Salvatore (“Lei è così disponibile“) o di Vittima (“Poverina, le hanno dato il progetto impossibile“), se assume posizioni ferme o fa domande dirette, rischia di essere etichettate come Persecutrice (“È aggressiva“, “È difficile da gestire“).
Questi bias non sono solo esterni: a volte sono interiorizzati e ci auto-limitiamo, evitando di prendere posizioni nette per paura di essere giudicate.
I giochi più comuni nel mondo del lavoro
Ora che abbiamo la mappa, esploriamo alcuni dei giochi più frequenti in ambito professionale.
Conoscere il nome di un gioco non serve per giudicare (sé o l’altra persona), ma per riconoscere quando ci stiamo dentro e scegliere se uscirne.
😥”Perché non… sì ma”
Come funziona:
Una persona presenta un problema e, a ogni soluzione proposta, risponde con “Sì, ma…” fornendo una ragione per cui non può funzionare.
Nel lavoro:
- “Non riesco a rispettare le scadenze” → “Perché non fai una pianificazione?” → “Sì, ma arrivano sempre urgenze“
- “Il team non mi ascolta” → “Perché non organizzi un meeting?” → “Sì, ma tanto sono sempre distratti“
Il “premio” nascosto:
Chi inizia il gioco facendo la domanda, in realtà cerca la conferma che la situazione è impossibile e che non è colpa sua. Chi risponde si sente utile, fino a quando si accorge che i suoi consigli vengono sistematicamente rifiutati, e allora arriva la frustrazione.
Bias di genere:
Spesso noi donne veniamo spinte a essere “aiutanti”, quindi cadiamo facilmente nel ruolo di chi offre soluzioni. E spesso ci sentiamo in colpa se non riusciamo ad “aiutare” davvero.
🦿”Gamba di legno”
Come funziona:
Una persona usa una sua caratteristica (reale o percepita) come scusa per non fare qualcosa o per ottenere trattamenti speciali.
Nel lavoro:
- “Sono troppo giovane per questo ruolo“
- “Non sono portata per la tecnologia“
- “Vengo da un’azienda piccola, qui funziona tutto diversamente“
Il “premio” nascosto:
Evitare responsabilità e rischi, ottenere protezione e comprensione.
Bias di genere:
Quanto volte abbiamo sentito (o detto) “Non sono brava con i numeri” o “Non sono una leader naturale“? Alcuni “difetti” sono socialmente più accettabili per le donne, e questo può trasformarsi in una trappola.
💔”Spalle al muro (variante)”
Come funziona:
Una persona fa qualcosa di lievemente provocatorio per spingere l’altra a reagire emotivamente, poi la critica per la reazione.
Nel lavoro:
- Commenti sottilmente sessisti seguiti da “Era solo uno scherzo, non essere così suscettibile“
- Critiche velate al lavoro di qualcuno in riunione, poi “Non volevo offendere“
- Interruzioni continue seguite da “Lasciami finire” quando l’altra persona protesta
Il “premio” nascosto:
Chi lancia la provocazione conferma che l’altra persona è “difficile” o “eccessiva”. Chi abbocca spesso si sente in colpa per aver reagito.
Bias di genere:
Questo gioco è particolarmente insidioso per le donne, perché spesso vengono giudicate più duramente quando reagiscono emotivamente. Il rischio è di interiorizzare il messaggio che siamo “troppo sensibili”.
👎”Il Difetto”
Come funziona:
Una persona trova sistematicamente qualcosa che non va nel lavoro degli altri, indipendentemente dalla qualità reale.
Nel lavoro:
- Il capo che trova sempre qualcosa da correggere, anche nei progetti migliori
- Il collega che critica ogni proposta senza mai offrire alternative
- La riunione che si trasforma sempre in un elenco di problemi senza soluzioni
Il “premio” nascosto:
Chi trova difetti si sente superiore e necessario. Chi li subisce spesso si convince di non essere mai abbastanza bravo.
Bias di genere:
Il lavoro delle donne è spesso sottoposto a scrutinio maggiore. Quello che per un uomo è “attenzione al dettaglio”, per una donna può diventare “perfezionismo eccessivo”.
⚖️”Il Tribunale”
Come funziona:
Una persona coinvolge altri per giudicare una situazione, invece di affrontarla direttamente con chi è coinvolto.
Nel lavoro:
- Lamentarsi del comportamento di un collega con tutti tranne che con lui
- Portare ogni piccolo conflitto al capo invece di risolverlo in autonomia
- Trasformare il team meeting in un processo pubblico
Il “premio” nascosto:
Chi porta in tribunale evita il confronto diretto e cerca alleati. Gli altri si sentono importanti perché coinvolti nel “giudizio”.
Bias di genere:
Le donne vengono spesso accusate di “fare pettegolezzi” quando in realtà stanno cercando supporto o validazione per situazioni difficili.
⏰”Occupatissima”
Come funziona:
La persona si presenta sempre sopraffatta dagli impegni. È sommersa, indispensabile, senza un attimo di tregua. Ogni richiesta, proposta o confronto viene disinnescato con varianti di: “Mi piacerebbe, ma non ho tempo”, oppure “In questo momento non riesco neanche a respirare”.
Nel lavoro:
- “Vorrei tanto partecipare, ma ho già tre progetti aperti.”
- “Scusa se non ti ho risposto prima, è una settimana infernale.”
- “Non riesco a delegare, preferisco fare tutto io: così va più veloce.”
Il “premio” nascosto:
Chi gioca a Occupatissima ottiene spesso delle carezze (un termine che in Analisi Transazionale indica i riconoscimenti) sotto forma di ammirazione. Ad esempio: “Ma come fai?”, “Sei un treno!”. Intanto evita di esporsi a richieste scomode o a momenti di confronto, mantenendo un senso di controllo apparente. A volte è anche un modo elegante per dire “no” senza prendersene la responsabilità.
Alla lunga, il gioco può isolare. Chi lo mette in atto può risultare poco accessibile o addirittura giudicante verso chi ha ritmi diversi. Chi interagisce può sentirsi respinta, svalutata o in colpa anche solo per aver chiesto supporto.
Bias di genere:
Il ruolo della donna super impegnata, multitasking e instancabile è ancora ampiamente valorizzato. Dire che si è occupatissime può sembrare un modo legittimo per farsi riconoscere, ma rischia di diventare l’unica via accettabile per non esserci. In questo contesto, il gioco rinforza l’idea che valiamo solo se ci stanchiamo abbastanza – e che dire “no” apertamente sia inaccettabile o da giustificare.
Quando i giochi diventano “creativi”
I giochi che abbiamo visto sono quelli catalogati da Berne e dai suoi allievi, ma la realtà è più ricca e complessa. Nel mondo del lavoro contemporaneo, soprattutto quando si intrecciano dinamiche di genere e di potere, nascono continuamente nuove varianti.
Alcuni esempi che potresti riconoscere:
“L’Esperta”: ti coinvolgono in progetti complessi perché “Sei così competente“, ma poi prendono le decisioni senza di te.
“La Diplomatica”: ti chiedono sempre di mediare nei conflitti perché “Hai un tocco speciale“, ma mai di prendere posizioni di leadership.
“La Perfezionista”: ogni tuo errore viene amplificato perché “Sai, da te ci aspettiamo di più“, mentre gli stessi errori negli altri passano inosservati.
“La Disponibile”: ti affidano sempre i compiti “urgenti” o “delicati” perché “sappiamo che non dici mai di no”, fino a sovraccaricarti. (Si associa bene anche a “Occupatissima”).
La creatività umana nel creare nuovi giochi è infinita ed è alimentata da stereotipi e aspettative implicite.
Come riconoscere quando sei in un gioco
Spesso ci accorgiamo di essere in un gioco solo quando è troppo tardi, quando cioè ci sentiamo già svuotate, arrabbiate o confuse. Ma con un po’ di allenamento, possiamo imparare a riconoscere i segnali prima.
Segnali emotivi
- Sensazione di “già visto”: se ti sembra di aver già vissuto questa situazione identica con la stessa persona, probabilmente è così.
- Emozioni sproporzionate: rabbia, frustrazione o tristezza che sembrano eccessive rispetto a quello che è successo “oggettivamente”.
- Senso di vuoto o confusione: dopo la conversazione ti senti scarica, anche se apparentemente non è successo nulla di drammatico.
- Senso di colpa inspiegabile: ti senti responsabile di qualcosa che non dipende da te, o in colpa per reazioni che ti sembravano normali.
Segnali relazionali
- Rigidità dei ruoli: ti accorgi che con certe persone finisci sempre nello stesso ruolo (quella che aiuta, quella che subisce, quella che critica).
- Comunicazione circolare: le conversazioni girano sempre attorno agli stessi temi senza mai arrivare a una conclusione.
- Impossibilità di uscire: provi a cambiare dinamica ma sembra impossibile, come se ci fosse una forza che ti riporta sempre al punto di partenza.
Segnali comportamentali
- Automazione: ti accorgi di rispondere in modo automatico, senza davvero scegliere.
- Evitamento: inizi a evitare certe persone o situazioni perché “sai già come andrà a finire”.
- Giustificazioni eccessive: ti ritrovi a spiegare o giustificare comportamenti che dovrebbero essere normali.
Come uscire dai giochi: energizzare l’Adulto
Riconoscere un gioco è il primo passo, ma come se ne esce? La via principale nell’Analisi Transazionale è attivare lo Stato dell’Io Adulto – il tuo e, possibilmente, quello dell’altra persona.
Energizzare il tuo Adulto
L’Adulto è quella parte di noi che sa stare nel presente, raccogliere informazioni senza giudicare, valutare le opzioni e fare scelte consapevoli. Quando sei nell’Adulto:
Energizzare l’Adulto dell’altra persona
Un gioco ha bisogno di almeno due persone che “giocano” dai loro Stati dell’Io Bambino o Genitore. Se tu rimani nell’Adulto e inviti anche l’altra persona a farlo, spesso il gioco si interrompe naturalmente.
Come fare? Rivolgiti all’Adulto dell’altra persona invece che al suo Bambino o Genitore:
Un esempio pratico
Immagina di essere nel gioco “Perché non… sì ma” con una collega:
Lei: “Non riesco mai a finire i progetti in tempo, è impossibile!”
Tu (dall’Adulto): “Sembra una situazione frustrante. Che cosa credi ti aiuterebbe di più in questo momento?”
Lei: “Non lo so, ho già provato tutto…”
Tu (energizzando il suo Adulto): “Tu che conosci meglio di me i tuoi progetti, che pattern noti? C’è qualcosa che ti ricorda una situazione simile che hai già risolto?”
Invece di entrare nel ruolo di Salvatore offrendo soluzioni, stai invitando la sua parte Adulta a osservare e analizzare. Spesso questo è sufficiente per interrompere il gioco e iniziare uno scambio più centrato e costruttivo.
Bias e stereotipi che alimentano i giochi
I giochi psicologici non nascono nel vuoto: si nutrono delle aspettative sociali, dei ruoli di genere e dei bias che attraversano i nostri contesti lavorativi. Per chi lavora in ambienti a maggioranza maschile, alcuni di questi bias possono essere particolarmente insidiosi.
Il bias della donna disponibile
Come si manifesta: l’aspettativa che le donne siano naturalmente più collaborative, pazienti, disposte ad aiutare.
Giochi che alimenta: “Perché non… sì ma” (nel ruolo di Salvatrice)
Come reagire: impara a dire “Non posso occuparmene ora” senza sentirti in colpa. Non tutti i problemi degli altri sono tuoi da risolvere.
Il bias della perfezionista
Come si manifesta: standard più alti per le donne, meno tolleranza per gli errori, aspettativa di controllo totale sui dettagli.
Giochi che alimenta: “Il Difetto” (come Vittima), “Occupatissima”, “Gamba di Legno” (quando interiorizziamo l’idea di non essere mai abbastanza).
Come reagire: distingui tra standard professionali legittimi e richieste eccessive. Non tutto deve essere perfetto per essere buono.
Il bias dell’emotività femminile
Come si manifesta: l’idea che le donne siano più emotive, meno razionali, più “sensibili”.
Giochi che alimenta: “Spalle al Muro” (come Vittima), “Il Tribunale” (quando le nostre reazioni vengono sminuite come “drammi”).
Come reagire: le tue reazioni emotive spesso sono dati importanti su quello che sta succedendo. Non scusarti per provare emozioni, ma impara a esprimerle in modo efficace.
Il bias della competizione tra donne
Come si manifesta: l’aspettativa che le donne non si supportino a vicenda, ma siano in competizione costante
Giochi che alimenta: “Il Tribunale”, “Il Difetto” (tra colleghe).
Come reagire: rifiuta di partecipare a giochi che mettono le donne una contro l’altra. Cerca invece alleanze e supporto reciproco.
Il doppio standard della leadership
Come si manifesta: comportamenti che negli uomini sono visti come leadership, nelle donne vengono etichettati come aggressività o difficoltà.
Giochi che alimenta: il rischio di auto-limitarsi per paura di essere giudicate, o al contrario di esagerare per dimostrare autorevolezza.
Come reagire: trova il tuo stile autentico di leadership, senza scusarti per occupare spazio o per prendere decisioni.
Creare nuove dinamiche: alternative ai giochi
Uscire dai giochi non significa solo smettere di farli, ma anche creare alternative più sane e soddisfacenti. Come possiamo trasformare le nostre interazioni lavorative in scambi più veri, più liberi e più efficaci per tutte le persone coinvolte?
Dalla transazione-gioco alla transazione-adulta
Invece di alimentare ruoli fissi, possiamo sperimentare comunicazioni più dirette:
Invece di:
“Mi dispiace disturbarti, ma potresti forse dare un’occhiata a questo quando hai tempo?” (Bambino Adattato)
Prova:
“Ho bisogno di un feedback su questo progetto entro venerdì. Hai mezz’ora questa settimana per farlo insieme?” (Adulto)
Invece di:
“È sempre la solita storia, nessuno fa mai niente come si deve” (Genitore Critico)
Prova:
“Ho notato che negli ultimi progetti i tempi non sono stati rispettati. Che cosa possiamo cambiare per la prossima volta?” (Adulto)
Coltivare carezze positive
Come abbiamo visto, le carezze in Analisi Transazionale sono tutte le forme di riconoscimento che ci scambiamo. I giochi spesso nascono quando c’è scarsità di carezze positive e genuine.
Carezze positive che puoi dare:
- Riconoscimenti specifici per il lavoro ben fatto
- Feedback costruttivi che aiutano a crescere
- Ascolto autentico quando qualcuno condivide difficoltà
- Supporto concreto quando richiesto
Carezze positive che puoi chiedere:
- Feedback regolari sul tuo lavoro
- Riconoscimento per i risultati raggiunti
- Supporto quando affronti sfide nuove
- Spazio per esprimere le tue idee
Costruire relazioni basate sul contratto chiaro
Un “contratto” in Analisi Transazionale è un accordo esplicito su cosa facciamo, perché lo facciamo e come lo facciamo. Nei rapporti lavorativi, avere contratti chiari può prevenire molti giochi.
Esempi di contratti chiari:
- “Il mio ruolo in questo progetto è X, il tuo è Y“
- “Quando hai bisogno di supporto, chiedimelo direttamente“
- “Cerchiamo di dare e ricevere i feedback in forma costruttiva“
- “Le decisioni su questo tema le prendiamo insieme in riunione“
Quando i giochi non si fermano
A volte, nonostante tutti i nostri sforzi, alcune persone cercano continuamente di coinvolgerci in giochi psicologici. In questi casi, è importante avere strategie di protezione e sapere quando è il momento di mettere confini più netti.
Segnali di persistenza
- La persona ignora completamente i tuoi tentativi di cambiare dinamica.
- Ti senti costantemente sotto pressione quando interagisci con lei.
- I tuoi colleghi notano che “Con lei non si riesce a lavorare normalmente“.
- La situazione inizia a influenzare il tuo benessere anche fuori dal lavoro.
Strategie di protezione
Documentazione: tieni traccia degli scambi problematici, soprattutto se coinvolgono questioni professionali importanti.
Testimoni: quando possibile, affronta conversazioni delicate con testimoni presenti.
Comunicazione scritta: usa email o messaggi per formalizzare accordi e decisioni.
Supporto: cerca il supporto di colleghi, superiori o delle risorse umane quando la situazione diventa insostenibile.
Quando chiedere aiuto
Se i giochi psicologici diventano sistematici e influenzano significativamente il tuo lavoro o il tuo benessere, può essere utile cercare supporto professionale:
- Counseling aziendale: se disponibile nella tua organizzazione, oppure counseling di gruppo.
- Mentoring: una figura esperta che ti aiuti a navigare le dinamiche complesse.
- Psicoterapia: quando i pattern si ripetono non solo nel lavoro, ma in più contesti della tua vita.
Verso relazioni più autentiche
I giochi psicologici sono parte dell’esperienza umana, li giochiamo tutti, spesso senza rendercene conto, perché rispondono a bisogni reali anche se in modi disfunzionali.
L’obiettivo non è diventare perfette nell’evitare i giochi, ma sviluppare la consapevolezza per riconoscerli e la flessibilità per scegliere alternative più sane, quando possibile.
Nel mondo del lavoro, dove le pressioni sono alte e i ruoli spesso rigidi, questa consapevolezza può fare la differenza tra relazioni che ci nutrono e ci fanno crescere, e relazioni che ci esauriscono e ci limitano. Ogni volta che rifiutiamo di partecipare a un gioco distruttivo, ogni volta che proponiamo un’alternativa più diretta e rispettosa, stiamo contribuendo a creare spazi di lavoro più sani per tutte e tutti.

Vuoi approfondire?
Se questi temi ti interessano o ti toccano nel vivo, hai diverse opzioni per migliorare la tua comunicazione professionale.
Puoi iscriverti a “Costruire Comunicazione”, il percorso in piccoli gruppi: include un modulo specifico sui giochi psicologici, con esercizi pratici e strumenti per il tuo sviluppo professionale. Se invece preferisci un supporto specifico e su misura, posso affiancarti in un percorso di Mentoring individuale.
I giochi psicologici non sono il nostro destino: sono pattern che possiamo riconoscere, comprendere e trasformare, per diventare professioniste più consapevoli e in controllo della nostra comunicazione.
Se hai dubbi o domande scrivimi usando il modulo di contatto, ti risponderò al più presto
