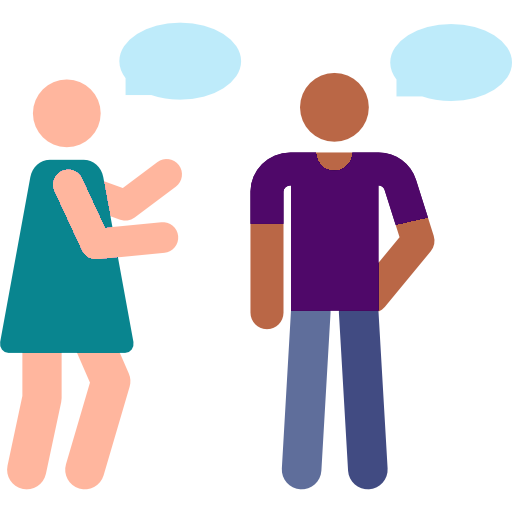
Assertività femminile e bias di genere: guida pratica all’ok-ness
L’assertività è, tutto sommato, un concetto semplice. Si tratta di dire quello che pensiamo e far valere il nostro punto di vista, il tutto mettendo confini chiari e senza invadere quelli altrui.
Ma se sei una donna e sei al lavoro, tutto si complica.
Quando una donna prende parola con chiarezza può essere percepita come fredda. Se difende un’idea con decisione, diventa aggressiva. Se chiede rispetto, “se la prende troppo”.
Assertiva? Sì, ma con il tono giusto, il sorriso giusto, la misura giusta. E il risultato è che in molte impariamo a parlare per attenuazione, facendo acrobazie.
Questa guida nasce per guardare dentro l’assertività e capire come possiamo essere assertive in contesti in cui (ancora) ci è difficile esserlo rimanendo coerenti con noi stesse.
Cos’è l’assertività (e perché non è solo un modo di comunicare)
Assertività, nella sua definizione più chiara, significa saper esprimere i propri bisogni, opinioni e limiti nel rispetto di sé e delle altre persone.
È la capacità di sentirsi ok quando si prende parola, cioè in una posizione di parità, non sopra né sotto. È parlare con la voce dello Stato dell’Io Adulto, che sceglie parole e azioni senza farsi tirare da vecchi insegnamenti, aspettative altrui o impulsi emotivi.
Per molte donne essere assertive è ancora un lusso. Perché veniamo educate a compiacere, a mediare, a stare “un passo indietro”. Perché nel lavoro, pur se siamo competenti, affidabili, brave, ci viene chiesto di essere anche accondiscendenti e di parlare sottovoce.
La società ci ha abituate così, il nostro Genitore Culturale è molto forte, così forte che spesso siamo le prime a dubitare del nostro diritto a dire con voce sicura: “Si fa così”.
Cosa troverai in questa guida
Con questa guida ti accompagnerò in un percorso in tre tappe: comprendere, decostruire e agire.
Capiremo insieme perché l’assertività non è una soft skill ma un atto di autodeterminazione.
L’angolo della teoria – Analisi Transazionale in pillole
In questa guida parlo di tre concetti dell’Analisi Transazionale: finora magari li hai intuiti, ma a questo punto te li presento brevemente, in modo che da qui in poi “parliamo la stessa lingua”.
Stati dell’Io
Genitore
(norme e giudizi interiorizzati, protezione, insegnamenti)
Adulto (integrato)
(dati, logica, integrazione di Genitore e Bambino nel presente)
Bambino
(emozioni, creatività o adattamento)
Perché ti serve
Riconoscere “chi” sta parlando dentro di te ti permette di scegliere risposte più funzionali.
L’Adulto che integra insegnamenti (Genitore) e emozioni (Bambino) nel presente e nella realtà è il modo più efficace di essere te stessa al lavoro.
Posizioni di vita
L’assertività vive nella prima posizione: rispetto reciproco. Abbiamo lo stesso valore come persone, non per forza le stesse competenze.
Genitore Culturale
Insieme di regole sociali assorbite senza accorgercene (es. “Le brave ragazze non alzano la voce”).
Perché ti serve
Individuare i messaggi che ti frenano ti consente di farli presente (se vuoi/puoi) e riscriverli in chiave adulta e assertiva.
Gli Stati dell’Io nella comunicazione
Quando parla il Genitore:
il tono si fa prescrittivo (“Devi consegnare subito”). Se prevale il critico, rischi di scivolare nell’aggressività; se domina il protettivo, potresti diventare invadente o svalutante (“Non preoccuparti, faccio io, non voglio che sbagli”). Quando il Genitore è negativo la posizione di vita è “Io sono ok, tu non sei ok”.
Quando parla il Bambino:
puoi cedere anche quando non vorresti (Bambino adattato: “Va bene, faccio come dici tu”) o ribellarti (“Non mi interessa, non lo faccio”). In entrambi i casi l’assertività si perde. Se sei nel Bambino negativo la posizione di vita può essere “Io sono ok, tu non sei ok” o viceversa.
Quando parla l’Adulto:
resti nei fatti, riconosci emozioni, formuli richieste chiare. Qui nasce la comunicazione assertiva.
Lo Stato dell’Io Bambino e Genitore non sono per forza negativi: il Genitore può essere anche protettivo e incoraggiante, e il Bambino entusiasta e libero di esprimersi.
Nel mondo del lavoro vedere espressi questi Stati in modo positivo è raro: teoricamente dovrebbe prevalere l’Adulto integrato, ed è comune trovare Genitore e Bambino nelle loro versioni negative e svalutanti.
Tre passi per riposizionarti in “Io ok – Tu ok”
Allenare l’Io Adulto al lavoro
La comunicazione efficace è un allenamento ed è più una maratona che uno sprint. Ti puoi allenare a comunicare con lo Stato dell’Io Adulto integrato con piccoli passi, e piano piano diventerà per te naturale utilizzarlo.
- Prima di rispondere a un’email o in riunione, fermati: ascoltati e fai magari un respiro, prenditi qualche istante per raccogliere le idee e integrare la risposta che ti verrebbe istintiva con il presente e la situazione, e poi prendi la parola.
- Man mano che ti accadono, osserva le situazioni in cui ti senti Io non ok – Tu ok o Io ok — Tu non ok. Annotale da qualche parte e poi scrivi come avresti potuto portarti in Io ok – Tu ok. Non è un modo per giudicarti, ma per osservare ciò che ti succede con gentilezza e curiosità, e allenarti per sentirti meglio.
- Allenati a essere assertiva con una collega: quando vi dovete dire qualcosa fatelo con lo schema “evento osservabile – bisogno – richiesta”. Poi confrontatevi sulle sensazioni che provate, in modo da affinare la tecnica.
Con questi strumenti passerai dal reagire allo scegliere come comunicare.
Cos’è l’assertività e perché è un tema di genere
Assertiva, aggressiva o passiva?
In Analisi Transazionale si parla di stili comunicativi e posizioni di vita:
Assertivo
Assertività significa riconoscere pari dignità ai bisogni di entrambe le parti: dici “Questo è importante per me” senza sminuire l’altra persona.
Passivo
Passività è non esporsi sperando che le altre persone si accorgano dei nostri bisogni: “Tengo basso il profilo così non disturbo”. Lo paghi in autostima e riconoscimento (le persone non si accorgono dei tuoi bisogni, e se lo fanno non si sentono obbligate a rispettarli, se non sei tu a chiederlo).
Aggressivo
Aggressività è l’errore speculare: per farti sentire alzi il volume, ma invece che diventare più autorevole diventi più autoritaria. Alla lunga ti isoli e crei resistenze.
Il trucco? Passare dallo Stato dell’Io del Bambino adattato (“Non valgo abbastanza”) o dal Genitore critico (“Devo imporre”) allo Stato dell’Io Adulto, dove valutiamo dati, emozioni e contesto nel qui e ora.
Perché il genere complica le cose
Il Genitore Culturale
Il Genitore Culturale insegna alle bambine a essere accomodanti. Il messaggio implicito è: “Sii gentile, non fare storie”. Quando crescendo provi a essere assertiva, stai violando quel copione e scatta la sanzione sociale: vieni etichettata come “difficile”, “ambiziosa” (chissà perché per una donna è una cosa negativa, mentre per gli uomini è positiva, no?) o “bossy”.
Il bias di genere
A parità di parole e contenuto, il comportamento viene valutato in modo diverso a seconda di chi lo mette in atto.
- Se un collega uomo afferma con fermezza: “Questo progetto non è prioritario, rimandiamolo“, spesso viene letto come un segno di schiettezza o di leadership (uno che “dice pane al pane”).
- Se a pronunciare la stessa frase, con lo stesso tono, è una collega donna, più facilmente viene etichettata come aggressiva o poco accomodante.
Questa distorsione percettiva è un bias di genere: un pregiudizio automatico che associa la determinazione alla mascolinità e la gentilezza alla femminilità.
Sapendo (anche inconsciamente) che verremo giudicate più severamente, noi donne finiamo per compensare smussando il messaggio: abbassiamo la voce, aggiungiamo sorrisi, inseriamo faccine o formule di scusa.
È un aggiustamento strategico ma faticoso, e spesso riduce l’efficacia della comunicazione assertiva.
La trappola del double bind (doppio vincolo)
I double bind sono quei messaggi senza via d’uscita che spesso riceviamo in ambito lavorativo, per esempio
- Ti dicono: “Sii più sicura di te” → Ti esprimi con fermezza → “Calmati, non serve alzare i toni”.
- “Fatti valere” → Negozi lo stipendio → “Sei troppo esigente”.
Qualunque scelta fai, sbagli. E quindi o tendi a tornare nella passività o ti logori cercando la dose “accettabile” di fermezza.
Come uscirne: micro-strategie per esercitarsi
Energizza lo Stato dell’Io Adulto
Prima di parlare, respira e chiediti: “Qual è il dato oggettivo? Qual è il bisogno in gioco?”. Nomina l’evento, poi il sentimento, poi la richiesta chiara: “Il progetto è in ritardo di due giorni. Mi preoccupa l’impatto sul cliente. Vorrei rivedere insieme le priorità per consegnare entro venerdì.”
Riformula il “no” come proposta
Invece di “Non posso farlo”, prova: “Per rispettare la scadenza che hai indicato, dovrei posticipare X o ricevere supporto su Y”. Resti ferma senza chiudere la porta.
Monitora il linguaggio attenuante
Limita parole come “forse”, “solo”, “scusami se” quando non sono necessarie. Allenati a parlare per punti: evento-bisogno-richiesta (come al punto 1).
Prepara una via d’uscita dal double bind
Tieni pronta una frase che smascheri la contraddizione: “Mi chiedi di prendere decisioni rapide ma di consultare sempre il team. Come possiamo bilanciare entrambe le esigenze?”
Cerca alleate e testimoni
Condividi gli obiettivi e fai pratica di assertività con una rete di colleghe (o crea un gruppo sicuro in cui farlo) e scambiate feedback osservabili, non giudicanti.
Essere assertive significa dare una forma reale all’idea io sono ok, tu sei ok.
L’assertività è come un muscolo che si allena con esercizi quotidiani, si nutre di consapevolezza, si rafforza con la pratica collettiva.
Bias culturali e stereotipi di genere
I bias e gli stereotipi sono scorciatoie della mente: veloci, automatiche, spesso invisibili. Ci servono per semplificare la realtà e incasellarla in qualcosa che conosciamo già, per gestirla meglio. Sul lavoro diventano ostacoli concreti alla tua efficacia e, di riflesso, alla tua crescita professionale.
Sono l’area in cui si muove il Genitore Culturale.
Riconoscere i bias
Diamo un nome ai bias più espliciti: se li conosci e li puoi nominare hai anche la possibilità di cercare un modo per smontarli.
Likeability penalty (penalità di piacevolezza)
Indica il prezzo pagato in “piacevolezza” quando una donna mostra autorevolezza.
Immagina di entrare in sala riunioni con la tua proposta sotto braccio. L’hai preparata curando ogni dettaglio, la presenti con voce ferma e in fondo alla tavola senti un brusìo: “Eh, però così sembra un po’ categorica“.
Questa è la penalità di piacevolezza: più mostri competenza e assertività, meno vieni ritenuta piacevole, simpatica. Per assurdo, se avessi balbettato saresti apparsa più “carina”, piacevole da ascoltare.
Nella nostra società, il Genitore Culturale pretende che le donne siano accoglienti e gentili, perciò la tua determinazione viene letta come freddezza o arroganza.
Quando siamo noi stesse ad aderire a questo bias cerchiamo per esempio di limare i feedback spiacevoli pur di non risultare antipatiche.
Prove it again (dover dimostrare sempre di più)
Sottolinea la richiesta ripetuta di prove di competenza già acquisite, o anche la dimostrazione continua di essere più competente dei colleghi uomini.
Per esempio, arriva una mail del cliente: “Ottima l’analisi, potresti aggiungere un confronto su tre anni e intervistare altri due clienti?“. Non è la prima volta che ti chiede di “arricchire” un lavoro già chiuso. E a Luca, seduto accanto a te, non capita quasi mai.
Questo è il bias del “dimostralo di nuovo”: a te si chiedono conferme continue su capacità già dimostrate. Report extra, numeri in più, referenze che al collega non vengono mai richieste. È un drenaggio di tempo ed energie e non è equo.
Maternal wall (barriera della maternità)
Evidenzia l’ostacolo percepito (o presunto) legato alla possibilità/presenza di figli.
Annunci che diventerai madre tra sei mesi. All’improvviso spariscono inviti a eventi serali e progetti importanti. Nessuno te lo dice esplicitamente, ma l’idea è che “tanto avrai altro per la testa”.
È la barriera della maternità: se hai figli (o pensano che potresti averne) vieni data per meno disponibile e meno interessata a fare carriera. Ci si aspetta che tu rinunci ai task strategici o alle trasferte, non ti vengono nemmeno proposte opportunità che si pensa tu non possa o voglia accettare.
Bias sul tono emotivo
Le emozioni espresse da una donna vengono spesso bollate come isteria o debolezza.
La riunione è tesa, il fornitore è in ritardo e tu lo fai notare. Dici: “Sono frustrata, rischiamo la penale“, qualcuno sussurra “Ecco, si scalda subito“. Se fossi un uomo saresti “appassionato per il tuo lavoro”, da donna diventi “emotiva”.
Questo è il bias sul tono emotivo: per questo motivo spesso le donne reprimono le loro emozioni al lavoro e aumentano il loro stress interno.
Allena il tuo Adulto integrato a esprimere le emozioni mantenendo il dato di realtà: sposta il discorso sui fatti, poi nomina l’emozione: “Sono contrariata per il ritardo: a oggi siamo a –15 % sul budget. Vorrei capire con il team come rientrare nei tempi“.
Conoscere questi stereotipi non serve a vittimizzarsi, ma a riconoscere il momento esatto in cui la partita smette di essere tecnica e diventa culturale.
Bias e assertività: strumenti pratici per allenarti a essere te stessa
In questa guida ho messo insieme assertività e bias perché per le donne diventare assertive è un percorso con molti più ostacoli rispetto a quello degli uomini, e i bias sono uno dei più grossi.
Puoi diventare più assertiva e farlo sarà più facile farlo conoscendo i bias e gli stereotipi che troverai lungo la tua strada.
Con gli strumenti giusti puoi stare sempre più spesso nello Stato dell’Io Adulto (che osserva, valuta e decide in modo equilibrato) e lasciare da parte il Genitore critico, quello Culturale e il Bambino adattato, sia tuoi che delle altre persone.
Vediamo da dove puoi iniziare.
Strumenti pratici per affrontare i bias al lavoro
La soluzione è energizzare lo Stato dell’Io Adulto e la posizione di vita “ok”: non devi aderire a uno standard, ma essere competente e fare bene il tuo lavoro.
Vediamo qualche esempio.
📓Il diario dei successi
Tratta i tuoi risultati come fatture: registrali, archiviali, tirali fuori all’occorrenza. Così, quando scatta il “dimostralo di nuovo”, non ti senti sotto esame: mostri la ricevuta e continui a guidare la conversazione.
Questa è una strategia tampone: serve un fronte comune perché le competenze di tutte smettano di essere messe in dubbio (lo vedremo nell’ultimo suggerimento).
🧮Chiedi trasparenza in pubblico
Quando intercetti uno stereotipo, riporta la conversazione allo Stato dell’Io Adulto. Per esempio: “Sì, il mio tono è fermo perché sono sicura di quello che sto dicendo, purtroppo i dati parlano chiaro“. Così eviti di passare per permalosa e costringi l’interlocutore a fondare la critica su elementi oggettivi (che spesso non ha). Usa lo schema “evento osservabile – bisogno – richiesta” che abbiamo già visto nel paragrafo dell’Adulto al lavoro.
🔮Preferisci il “feed-forward” al feed-back
Chiedi feedback sul futuro: invece di domandare “Cosa ne pensi del report che ho consegnato?” prova con “Quali aspetti vorresti vedere potenziati nel prossimo?”
Sposta l’attenzione dal giudizio retrospettivo – terreno del Genitore critico e dei pregiudizi – a indicazioni future, concrete e misurabili.
👥Costruisci reti informali quanto quelle formali
Non limitarti ai meeting ufficiali: partecipa (o organizza) pranzi, webinar interni, chat tematiche dove si scambiano opportunità e consigli. Molti bias prosperano in corridoi invisibili: presidiarli con la tua presenza adulta e assertiva riduce la distanza da chi decide promozioni e progetti.
E quando intercetti un’opportunità, anticipa il bias dichiarando disponibilità e confini: “Posso guidare l’intero progetto, prevedo di consegnare martedì; per eventuali urgenze fuori orario concordiamo un canale rapido“.
💡 In sintesi
Documenta, crea alleanze, rendi esplicito ciò che è implicito e sposta le discussioni sul futuro. Così trasformi i bias da ostacoli silenziosi a questioni gestibili.
Allenare l’assertività
Linguaggio, tono e postura: la tua cassa di risonanza
Quando comunichi, tre elementi lavorano insieme: le parole, il tono di voce e il corpo. Se scegli un linguaggio chiaro — evitando i “forse” o “solo”, “scusami” — energizzi il tuo Stato dell’Io Adulto. Il tono va calibrato: fermo ma non duro, deciso ma non urlato. Infine, la postura: spalle aperte, piedi saldi a terra, mani visibili (basta anche tenere in mano una penna).
Esercizio rapido: davanti allo specchio o in videochiamata con una persona di fiducia, presenta un punto chiave della tua giornata lavorativa. Osserva le parole che scegli, ascolta il tono e regola la postura finché non senti che corpo, voce e mente viaggiano in sincrono, tutti nello Stato dell’Io Adulto. Te ne accorgi quando succede perché ti senti bene, non ti sembra di interpretare una parte ma ti senti sicura di te mentre parli.
Stai alla larga da chi ti dice come devi muoverti, che tono di voce usare, che parole devi scegliere per essere efficace. Ti stanno proponendo soluzioni che possono stravolgere il tuo modo di essere, ti fanno sentire comunque a disagio, e funzionano solo in alcuni specifici casi.
Trovare il tuo modo di essere efficace è più complicato, ma ti garantisce che ti sentirai davvero te stessa e potrai realizzarti nel lavoro anche come persona, oltre che come professionista.
Gestire emozioni e feedback
In Analisi Transazionale si dice che, quando arrivano emozioni forti, il Bambino o il Genitore critico possono prendere il sopravvento. Per evitarlo, applica sempre lo schema “evento – bisogno – richiesta”:
- Evento: descrivi ciò che è accaduto senza giudizio.
- Bisogno: nomina il sentimento o il bisogno che hai vissuto.
- Richiesta: proponi un’azione concreta per andare avanti.
“Ieri, durante la riunione, ho sentito che le mie proposte non hanno trovato spazio (evento). Mi sono sentita frustrata perché desidero contribuire pienamente al progetto (bisogno). Potremmo dedicare un quarto d’ora nella prossima call per discuterle insieme? (richiesta)”.
Questo approccio mantiene l’Adulto al comando e trasforma il feedback in dialogo costruttivo.
Crea spazi sicuri e cerca alleanze
Scegli colleghe – e colleghi – che riconoscono i bias e vogliono come te allenare l’assertività. Fate in modo di supportarvi nelle riunioni e sostenere le vostre voci, organizzate incontri in cui potete confrontarvi insieme su eventi e reazioni. Non per giudicarvi o colpevolizzarvi, ma per allenarvi a riconoscere le situazioni e ad avere le risposte pronte.
Simulazioni reali: role-playing
Provare, provare, provare: è così che alla fine l’assertività diventa un tuo modo naturale di esprimerti. Organizza piccole simulazioni con una collega o in un gruppo di lavoro, per esempio:
- Ricevere una critica ingiusta: chi interpreta il ruolo del critico prova ad accusarti. Tu rispondi con lo schema evento-bisogno-richiesta, senza cadere nell’aggressività o nella passività.
- Dire no a un incarico extra: esercitati a spiegare perché non puoi accettare subito e a offrire un’alternativa (posticipare X, chiedere supporto su Y).
- Portare dati in riunione: simula la presentazione di un report con grafici e cifre, alternando interventi che riflettano il tuo diritto a parlare in modo chiaro e autorevole.
Dopo ogni simulazione, fate una restituzione: chi ha recitato il critico o il cliente espone come ha vissuto la tua assertività, e tu annoti come ti sei sentita, cosa ti ha aiutato a rimanere in Adulto e dove potresti migliorare.
Costruire una cultura dell’ok-ness
Come sempre negli spazi femminili nemmeno l’assertività è un concetto su cui si lavora da sole: per avere dei cambiamenti permanenti e per tutte e tutti è necessario trasformare l’intero contesto in cui operiamo. Una cultura dell’ok-ness è un ambiente in cui ogni voce ha uguale valore e può esprimersi dallo Stato dell’Io Adulto, libera dai meccanismi del Genitore Culturale.
Promuovere ambienti inclusivi e rispettosi
Regole chiare e condivise
Stabilisci insieme al team modalità di confronto (durata degli interventi, turni di parola, spazi di ascolto). Così riduci le ambiguità che spesso premiano chi alza la voce.
Momenti di riflessione
Cerca il più possibile di non incalzare le risposte, concedi spazi di riflessione in modo che tutte le persone nel tuo team possano avere il tempo per organizzare le idee e rispondere dal loro Stato Adulto.
Feedback strutturati
Usa lo schema evento-bisogno-richiesta come lingua comune per dare e ricevere commenti. In questo modo si mantiene il dialogo su un piano adulto e costruttivo, anziché scivolare in giudizi o reazioni emotive.
Il ruolo della leadership femminile
Quando una donna in posizione di responsabilità agisce dallo Stato dell’Io Adulto, sceglie il rispetto reciproco (io ok – tu ok) e indica la strada all’intero gruppo. Cosa può fare, quindi, una donna che ha una posizione apicale in un’azienda per supportare le altre?
L’assertività è un atto di autodeterminazione e un motore di cambiamento collettivo. Quando impari a entrare nello Stato dell’Io Adulto, non solo migliori la tua comunicazione, ma contribuisci a un ambiente in cui tutte le persone possono sentirsi ok – e far sentire ok gli altri. Così, passo dopo passo, si possono costruire insieme ambienti di lavoro in cui l’assertività femminile non è più un’eccezione, ma la regola.

Se questa guida ti è piaciuta, puoi iscriverti alla mia newsletter.
Si chiama Interdipendenze e tratta di temi di comunicazione efficace declinati nella realtà lavorativa e non, cercando collegamenti interessanti a cui potresti non aver pensato. Arriva più o meno una volta al mese, ma solo se ho qualcosa da dire.
Bibliografia
Analisi Transazionale
- Berne, E. (1961). Transactional Analysis in Psychotherapy: A Systematic Individual and Social Psychiatry. Grove Press. Fondazione degli stati dell’Io (Genitore, Adulto, Bambino)
- Berne, E. (1964). Games People Play: The Psychology of Human Relationships. Grove Press. Introduzione di giochi psicologici e copioni di vita
Bias di Genere
- Heilman, M. E. & Okimoto, T. G. (2007). “Why Are Women Penalized for Success at Male Tasks?” Journal of Applied Psychology, 92(1), 81–92. Studio classico sulla penalità di simpatia (likeability penalty)
- Williams, J. C., Phillips, K. W. & Hall, E. V. (2014). Double Jeopardy? Gender Bias Against Women of Color in Science. Center for WorkLife Law. Formalizza i bias “Prove-It-Again” e “Maternal Wall”
- Williams, J. C. & Dempsey, R. (2014). What Works for Women at Work: Four Patterns Working Women Need to Know. NYU Press. Sintesi dei quattro bias principali (Prove-It-Again, Tightrope, Maternal Wall, Tug of War)
- Moss-Racusin, C. A. et al. (2012). “Science faculty’s subtle gender biases favor male students.” Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(41), 16474–16479. Evidenza sperimentale sul pregiudizio di competenza
- Brescoll, V. L. & Uhlmann, E. L. (2008). “Can an Angry Woman Get Ahead?” Psychological Science, 19(3), 268–275. Analisi del bias sul tono emotivo
- Eagly, A. H. & Carli, L. L. (2007). “Women and the Labyrinth of Leadership.” Harvard Business Review, 85(9), 62–71. Riflessione sul doppio vincolo e sulle barriere strutturali
- European Institute for Gender Equality (EIGE). (2015). The Motherhood Pay Gap in Europe. Rapporto sulle penalità di carriera legate alla maternità (maternal wall)
Cultura organizzativa e pratiche inclusive
- Catalyst. (2024). “The Double-Bind Dilemma for Women in Leadership.” Infografica sulle aspettative contraddittorie
- Heilman, M. E. & Haynes, M. C. (2005). “Subjective Evaluations of Scholarly Work: Gender Bias in Academia.” Sex Roles, 52(1/2). Studio sui criteri soggettivi di valutazione
- Sandberg, S. (2013). Lean In: Women, Work, and the Will to Lead. Knopf. Proposte pratiche per l’empowerment femminile e gestione dei bias interiorizzati
- McKinsey & Company & LeanIn.Org. (2023). Women in the Workplace. Report annuale su rappresentanza e barriere organizzative
- Harvard Business Review. (2013). “For Women Leaders, Likability and Success Hardly Go Hand-in-Hand.” Caso “Heidi vs Howard” sull’effetto nome nei processi decisionali
